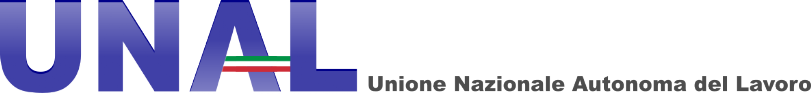Delitto di estorsione configurabile anche a carico del datore di lavoro che imponga ai propri sottoposti condizioni contrattuali svantaggiose
Notizie
Corte di Cassazione – sezione II penale – sentenza 21 settembre-5 ottobre 2007, n.36642
Nonostante la vicenda in esame costituisca espressione del “non eccezionale” fenomeno del lavoro nero, i giudici della Suprema Corte hanno ritenuto per essa comunque integrati gli estremi del delitto di estorsione, in quanto l’accordo contrattuale intervenuto tra datore di lavoro e dipendenti prevedeva l’accettazione da parte di questi ultimi di un trattamento retributivo inferiore ai minimi previsti per legge, oltre che di una serie di ulteriori condizioni assolutamente svantaggiose per gli stessi, coartati in tal modo nella loro volontà a fronte del rischio di poter perdere il posto di lavoro.
La Corte ha infatti evidenziato, con la sentenza in commento, come anche uno strumento di per sé legittimo possa essere utilizzato per finalità differenti da quelle per le quali esso è predisposto, andando così ad integrare, oltre alle apparenze, una minaccia ingiusta nel senso descritto dall’art.629 Cp, perchè ingiusto è il fine cui la stessa tende.
Il provvedimento sottoposto all’attenzione della Suprema Corte, riguardava una sentenza di condanna alla pena di anni 3, mesi 6 di reclusione ed euro 800,00 di multa, oltre alle spese dei due gradi di giudizio, emessa nel gennaio 2003 dalla Corte d’Appello di Cagliari – sez.distaccata di Sassari, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Nuoro resa nel novembre del 2000, che aveva assolto alcuni datori di lavoro, con formula perché il fatto non sussiste, dal contestato delitto di estorsione aggravata e continuata commessa in danno dei propri dipendenti.
I capi di accusa, poi confermati dalla Corte d’Appello, avevano indicato gli imputati quali responsabili di condotte estorsive esercitate nei confronti dei dipendenti, realizzatesi con imposizione agli stessi di trattamenti retributivi peggiorativi, non conformi alle effettive prestazioni lavorative svolte e, più in generale, di condizioni lavorative contrarie alla legge e ai contratti collettivi di lavoro, sfruttando situazioni di mercato nelle quali la domanda di lavoro era altamente superiore all’offerta e, quindi, ponendo i dipendenti in una condizione di suggestione morale, nella quale l’eventuale mancata accettazione dei patti contrattuali “vessatori” sarebbe equivalsa alla perdita del posto di lavoro.
La ricostruzione dei fatti operata dalla Corte territoriale si era avvalsa delle prove orali e documentali e, in particolare, delle indagini espletate dall’ispettorato del lavoro in relazione ai rapporti di impiego intercorrenti tra le parti.
Dagli accertamenti eseguiti era emerso che alcuni dipendenti erano stati assunti senza libretto di lavoro, erano privi di copertura assicurativa, non avevano usufruito delle ferie né dei corrispettivi ad essi spettanti per attività di lavoro straordinario e che avevano sottoscritto prospetti di paga per importi maggiori a quelli effettivamente corrisposti.
Una dipendente in particolare, era stata persuasa a firmare un contratto di associazione in partecipazione senza che la sua qualifica, in realtà, fosse variata, nonché a mentire agli ispettori del lavoro in ordine alla propria collocazione professionale e a sottoscrivere una dichiarazione mediante la quale si accollava, unitamente al fidanzato, la responsabilità per un furto di vestiario subito dall’azienda.
Altri dipendenti infine, avevano dovuto sottostare ad un trattamento conforme a quello del contratto di formazione lavoro, pur osservando orari di impiego superiori a quelli stabiliti dai contratti collettivi.
Secondo il giudicante in primo grado, nei fatti così evidenziati difettava invero l’elemento della minaccia del licenziamento illegittimo, connessa alla pretesa di prestazioni lavorative alle condizioni appena accennate.
Non si poteva ravvisare infatti per il Tribunale di Nuoro, nei fatti emersi in dibattimento, una coercizione della volontà dei dipendenti secondo un significato di rilevanza penale, atteso che “il licenziamento aveva costituito una condizione preesistente all’assunzione per i dipendenti che non avessero voluto accettare le chiare, anche se illegali, condizioni proposte dagli imputati”.
Ribaltando tale impostazione, la Corte d’Appello aveva riformato la prima sentenza e conferito invece piena idoneità alla condotta degli imputati nel produrre le conseguenze di natura penale in contestazione, atteso che la minaccia ben si poteva ravvisare nel comportamento complessivamente considerato, dal quale riuscivano di certo ad emergere l’ingiustizia della pretesa, la natura soverchiatrice dei soggetti agenti e le condizioni ambientali sicuramente favorevoli per i datori di lavoro. Nella specie, la Corte territoriale aveva rifiutato quanto sostenuto dagli imputati a propria discolpa (e cioè che le pretese avanzate in sede penale dai lavoratori dipendenti potevano e dovevano trovare tutela dinnanzi al Giudice del lavoro), posto che, tra l’altro, due dipendenti in particolare, seppur usciti vittoriosi dalle relative cause di lavoro intentate contro i vertici aziendali, nulla erano riusciti ad ottenere dagli stessi.
Avevano inoltre segnalato i giudici di secondo grado, che alcune circostanze si erano appalesate in maniera alquanto strana: così la dichiarazione sottoscritta da quella dipendente che si era addossata la responsabilità per il furto subito dall’azienda che, a dire di un teste escusso in dibattimento, sarebbe poi stata strumentalmente utilizzata dai titolari nei confronti della medesima dipendente, qualora si fosse opposta alle condizioni onerose di lavoro; ovvero la “fuga” imposta a quell’altro lavoratore, in occasione dell’ispezione eseguita in sede dall’ufficio del lavoro; ovvero ancora, il comportamento concretamente posto in essere dai datori, al fine di impedire ogni possibile dialogo tra dipendenti e ispettori del lavoro.
Inoltre, sempre secondo il Collegio del secondo grado, “…quand’anche si ritenesse intervenuto tra i titolari dell’azienda e i lavoratori un accordo contrattuale, non per questo andava esclusa la sussistenza dell’estorsione, da momento che, al di là dell’aspetto formale dell’accordo contrattuale, la condotta dei [titolari] risultava posta in essere nella sola prospettiva di conseguire un ingiusto profitto con altrui danno, quest’ultimo inteso come contributo di energie lavorative impiegate dalle persone offese a vantaggio del titolare dell’azienda in cambio di una retribuzione inferiore a quella dovuta e dichiarata nella busta paga”.
La Corte di Appello dunque, ribaltando il pronunciamento del giudice di prime cure, aveva così ritenuto gli imputati responsabili per il delitto di estorsione aggravata e condannato gli stessi.
Evidentemente una simile decisione non poteva che essere gravata da ricorso per cassazione ad opera degli imputati, censurandola sotto diversi profili di violazione della legge e vizi di motivazione, secondo i motivi tassativamente indicati dall’art.606 del Cpp.
Nella sostanza, i ricorrenti si dolevano del fatto che la Corte territoriale non aveva valutato in maniera appropriata la circostanza per cui le eventuali infrazioni alla normativa posta a tutela dei lavoratori, costituivano in realtà frutto di un accordo contrattuale, che seppur illecito o nullo ai sensi del codice civile, non poteva di certo integrare il requisito della minaccia penalmente rilevante ai fini della contestazione del delitto di estorsione.
La vicenda sottoposta all’attenzione dell’autorità giudiziaria costituiva infatti per la difesa dei ricorrenti, espressione del non eccezionale fenomeno del lavoro nero, dove la violazione della norme collettive discendeva dalla precisa pattuizione in tal senso tra le parti, sin dall’inizio, senza alcun ricorso alla violenza o alla minaccia.
Nel rigettare i ricorsi e condannare i ricorrenti in solido tra loro al pagamento delle spese processuali, la Suprema Corte ha inteso richiamare in primo luogo l’oggetto di tutela del reato di estorsione, precisando come esso si presenti in maniera bifronte, dato che la disposizione di cui all’art.629 Cp persegue allo stesso tempo l’interesse pubblico all’intangibilità del patrimonio e, nello stesso tempo, quello della libertà di autodeterminazione di ciascun individuo.
L’evento finale dell’ingiusto profitto con altrui danno, previsto dalla norma, deriva infatti dalla stessa vittima del reato in conseguenza ad un contesto di costrizione fisica o morale esercitata nei suoi confronti dal soggetto attivo.
“Il potere di autodeterminazione della vittima non è completamente annullato, ma è, tuttavia, limitato in maniera considerevole: in altri termini, il soggetto passivo dell’estorsione è posto nell’alternativa di far conseguire all’agente il vantaggio economico voluto ovvero di subire un pregiudizio diretto ed immeditato. In questa prospettiva [ prosegue la S.C. ] anche lo strumentale uso di mezzi leciti e di azioni astrattamente consentite può assumere un significato ricattatorio e genericamente estorsivo quando lo scopo mediato sia quello di coartare l’altrui volontà; in tal caso l’ingiustizia del proposito rende necessariamente ingiusta la minaccia di danno rivolta alla vittima e il male minacciato, giusto obiettivamente, diventa ingiusto per il fine cui è diretto (cfr.Cass.pen.sez.II, 17 ottobre 1973, n.877). Allo stesso modo la prospettazione di un male ingiusto può integrare il delitto di estorsione, pur quando si persegua un giusto profitto e il negozio concluso a seguito di essa si riveli addirittura vantaggioso per il soggetto destinatario della minaccia (cfr.Cass.pen.sez.II, 5 marzo-28 aprile 1992, n.1071). Ciò in quanto la nota pregnante del delitto di estorsione consiste nel mettere la persona minacciata in condizioni di tale soggezione e dipendenza da non consentirle, senza un apprezzabile sacrificio della sua autonomia decisionale, alternative meno drastiche di quelle alle quali la stessa si considera costretta (cfr.Cass.pen.sez.II, 7 novembre 2000, n.13043)”.
Ecco allora i motivi per cui la minaccia rilevante ai fini della configurabilità del delitto di estorsione può manifestarsi in varie foggie, essere esplicita o larvata, scritta ovvero orale, determinata o indeterminata, ovvero addirittura assumere la connotazione di esortazione o di consiglio. Ciò che assume rilevanza in ogni caso, è l’intenzione perseguita dall’agente, diretta ad ottenere un profitto ingiusto con altrui danno, oltre all’idoneità del mezzo impiegato per coartare la volontà e la capacità di autogoverno del soggetto passivo.
Il Collegio di legittimità ha dunque precisato che le doglianze sollevate dai ricorrenti andavano ritenute infondate sia in punto di fatto che di diritto, avendo la sentenza impugnata correttamente escluso la rilevanza del riferimento al contratto, quando questo – come nel caso di specie – venga utilizzato per scopi strumentali, con il solo fine di perseguire un ingiusto profitto, in circostanze ambientali caratterizzate da una situazione di timore dei dipendenti in virtù della coazione della loro volontà nell’accettazione di condizioni contrattuali gravose e inique, a fronte dell’impossibilità di reperire valide alternative di lavoro, data la situazione contingente del mercato del lavoro.
La Cassazione si è dunque manifestata lapidaria nel sostenere che “un accordo contrattuale tra datore di lavoro e dipendente, nel senso dell’accettazione da parte di quest’ultimo di percepire una paga inferiore ai minimi retributivi e non parametrata alle effettive ore lavorative, non esclude, di per sé, la sussistenza dei presupposti dell’estorsione mediante minaccia, in quanto anche uno strumento teoricamente legittimo può essere usato per scopi diversi da quelli per cui è apprestato e può integrare, al di là della mera apparenza, una minaccia, ingiusta, perché è ingiusto il fine a cui tende, e idonea a condizionare la volontà del soggetto passivo, interessato ad assicurarsi comunque una possibilità di lavoro, altrimenti esclusa per le generali condizioni ambientali o per le specifiche caratteristiche di un particolare settore di impiego della manodopera (ex plurimis Cass.pen.sez.II, 24 gennaio 2003, n.3779; Cass.pen.sez.I, 11 febbraio 2002, n.5426). E’ questione poi riservata al Giudice del merito valutare se la condotta dell’imputato sia stata posta in essere nella sola prospettiva di conseguire un ingiusto profitto con altrui danno, attraverso un comportamento che, al di là dell’aspetto formale dell’accordo contrattuale, ponga concretamente la vittima in uno stato di soggezione, ravvisabile nella alternativa di accedere all’ingiusta richiesta dell’agente o di subire un più grave pregiudizio, anche se non esplicitamente prospettato, quale l’assenza di altre possibilità occupazionali”.
A parere della S.C. invero, i giudicanti nel merito avevano enumerato in maniera chiara e puntuale una miriade di condotte prevaricatrici poste in essere dai datori di lavoro nei confronti dei propri dipendenti, con persistente disprezzo dei diritti degli stessi.
Ciò ha portato i giudici di legittimità a ritenere che, nonostante l’assenza di minacce esplicite, gli imputati si erano per il vero avvalsi della situazione di mercato per loro favorevole (in cui la domanda era nettamente superata dall’offerta di lavoro), e per tale via limitato il potere di autodeterminazione delle persone offese, mediante la minaccia larvata, altrettanto grave, di avvalersi di tale situazione.
Secondo la Corte di Cassazione in definitiva, le censure dei ricorrenti – peraltro ai limiti del merito – in ordine alla sussistenza di precise intese contrattuali tra le parti, devono ritenersi assolutamente infondate, atteso che “ciò che rileva agli effetti dell’art.629 Cp è che l’accordo non fu raggiunto liberamente ma (nella descritta situazione) estorto”.
CIO' VALE ANCHE PER I TITOLARI DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA CHE "RETRIBUISCONO" IL LAVORO STRAORDINARIO IN NERO